Certe volte e' difficile rappresentare la tristezza. Certe volte e' complesso tratteggiarne le sfumature, fotografarla per poi, in seguito, poterla mostrare ad altri, poterla raccontare. Provate ad immaginare la figura di una ragazza. Un'adolescente. Sola, impaurita, spaesata. Il suo viso e' pallido, i suoi occhi spenti ed inespressivi. Si trova sopra uno dei piu' importanti ponti di Londra. Con lo sguardo pericolosamente rivolto verso le acque del Tamigi, acque placide nelle quali scorrono i suoi vaghi ricordi, sfumature di emozioni e visioni confuse. Fa quasi freddo, e la nebbia allontana le luci della citta'.
Non male come ritratto della tristezza, non credete?
I Marillion hanno rubato quest'immagine alla realta' e ad essa hanno affidato il gravoso compito di introdurci dentro la malinconia sfuggente di "Brave", certamente il loro album piu' ambizioso e complesso, forse il loro principale capolavoro, un concept di estremo fascino, dal feeling quasi insostenibile. Il fatto realmente accaduto e' che nel 1988 una ragazza venne ritrovata, in preda ad un forte shock, sul Severn Bridge. Incapace di rispondere alle domande della polizia, venne riconosciuta dai genitori attraverso un appello radio. Perche' questa ragazza fuggi' di casa? Cosa ci faceva su quel ponte? Aveva forse intenzione di suicidarsi? Cosa le era accaduto nei giorni precedenti? A queste domande i Marillion (e Steve Hogarth in particolare, autore dei testi) hanno cercato di dare delle risposte, immaginando una storia di abusi sessuali da parte del padre, la fuga da casa, le inevitabili esperienze di droga e d'amore, fino al tentativo di suicidio. Il tutto descritto con minuzia di particolari e con impagabile sensibilita', e sottolineato da undici ariose e complesse composizioni (spesso suddivise, nel loro interno, in altre mini-canzoni) che rileggono i canoni del rock progressivo degli anni '70, attualizzandoli tramite il solito formidabile Marillion sound. "Brave" e', inoltre, uno degli album piu' complessi di sempre. Appare infatti del tutto privo di facili melodie e di ritornelli memorizzabili, e quasi si vanta del suo essere criptico e poco accessibile, tanto che qualcuno ha accusato l'album stesso di "egoismo", come se la band lo avesse scritto non per proporlo a terzi, ma per una pura e semplice necessita' personale. Resta il fatto che, una volta entrati dentro il disco, sara' difficile venirne fuori (illesi).
Dell'inizio regale ma intimo di "Bridge", tratteggiato da un'intensa melodia di tastiera, abbiamo gia' parlato, ma e' con "Living with the big lie" che inizia quel flashback che ci chiarira' (forse) i motivi che hanno spinto la protagostista ad accarezzare l'idea del suicidio. Il crescendo del pezzo non puo' che provocare brividi, Hogart alla voce e' di una delicatezza infinita, e tutta la band pare concentrarsi sui dettagli e non voler disturbare l'intenso dialogo tra il (bravissimo) singer e l'ascoltatore. Non poteva esserci inizio migliore. Segue quella "Runaway" che e' in pratica una vera e propria ballad, languida e malinconica, e le emozioni ancora una volta non vengono lesinate: credo che l'assolo di Rothery (un chitarrista che sa cosa significa "feeling") potrebbe commuovere anche i sassi. Il viaggio drammatico di "Brave" continua con "Goodbye to all that", suddivisa in sei parti, e il ritmo globale dell'album sale vertiginosamente ed in modo improvviso. A scanso di equivoci, e' doveroso dire che anche in questo pezzo abbondano le parti riflessive e pacate (molte di esse esclusivamente strumentali), e la cura degli arrangiamenti resta (come in tutto il disco), ai massimi livelli di perfezioni e creativita'. "Hard as love" e' invece un trascinante pezzo dall'andamento hard-rock, che ha forse il compito di affievolire un po' la tensione globale del lavoro, e il voluto effetto chiaro-scuro con la seguente ballad pianistica "The hollow man" e' pienamente riuscito. Gia', "The hollow man". Saltate questa traccia quando siete di buon umore, non avrebbe senso ascoltarla. Di una raffinatezza incredibile, arrangiata con la delicatezza di una jazz-band, "The hollow man", forse uno degli episodi piu' rassegnati e intensi dell'album, possiede una melodia straordinaria e particolarissima. Il ritmo viene accelerato (senza esagerare) con la successiva "Alone again with the lap of luxury", sempre triste ma vagamente piu' catchy, e con "Paper lies", tirata e coinvolgente e piu' disimpegnata delle altre. La lunga e dilatata title-track, dal sapore celtico, resa superba dalla grande interpretazione di un Hogarth che dimostra la sua classe per tutta la durata del disco, e' il preludio all'arrendevole melodia di "The great escape", la grande fuga dal mondo, lungo e lacrimevole testamento, altro picco di emozioni, con la chitarra di Rothery che sembra piangere con la protagonista della storia. Un brano quasi imbarazzante: e' difficile doversi confrontare in modo cosi' diretto e improvviso con le proprie emozioni, trovarsi davanti alla faccia le proprie paure e non poterle piu' negare o nascondere. Sinceramente splendido. Il disco si chiude con lo squarcio di sole di "Made again", testo da incorniciare e grande melodia, per una canzone acustica troppo bella per essere descritta. E cosi' finisce il viaggio, cosi' finisce questo disco, tra l'altro importantissimo per il rock progressivo degli anni '90 (ha influenzato certamente i Fates Warning del magnifico "A pleasant shade of grey"). Un album imprescindibile. Emozionante come pochi altri. Da ascoltare in cuffia, con l'umore giusto. Mentre magari fuori piove. Magari e' pure autunno, magari fa pure freddo. Un album terribile, sotto certi punti di vista, che potrebbe metterci nudi davanti a noi stessi. Sappiate che tutto cio' potrebbe essere doloroso. E' doloroso guardare giu' dal quel ponte, assieme a quella ragazza, soprattutto quando ci accorgiamo che cio' che quelle acque le mostrano alcune volte non e' dissimile da quello che potremmo vedere noi al suo posto. E se un disco riesce a trasmettere tutto questo, non puo' essere che un capolavoro. Da avere.
|
MARILLION - brave (1994)
|
Maggio 2000
|
|
 |
VOTO: 1/1
Gianluca "Geoff" |
|
|
INFO:
Anno: 1994 Etichetta: EMI Durata: 71 minuti |
||
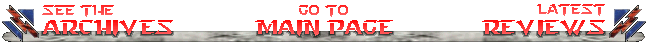
|
||